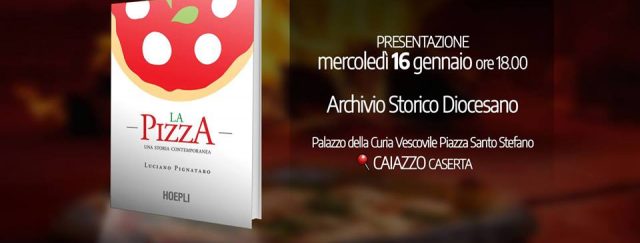Emilia-Romagna: lo stato dell’arte

Una bellissima manifestazione, non c’e bisogno di altre parole per qualificare Enologica, che da qualche anno si tiene a Bologna nel palazzo Re Enzo in piazza Maggiore. La supervisione di Giorgio Melandri, creatore dell’evento sotto l’egida dell'Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna, permette una serie di seminari sui vini e sui vitigni autoctoni della regione estremamente accattivanti e densi di contenuti. La sala degustazione ha un solo difetto: l’acustica veramente pessima che nei momenti di maggior affluenza genera un brusio fastidioso, ma stiamo cercando l’ago nel pagliaio. Ottima la regia e l’assistenza che si riceve grazie al lavoro puntuale, gentile e mai invadente di Pierluigi Papi responsabile delle P.R.
Nella sala sempre gremita da un pubblico attento e consapevole abbiamo i migliori produttori della regione divisi per comune, cosa che rende agevole il confronto tra vini della stessa zona, permettendo all’appassionato e al professionista di capire le grandi diversità delle zone e dei territori che le compongono. Anche l’interpretazione del sangiovese romagnolo che risente in modo sensibile di questi cambiamenti è facilitata, come la differenza tra il Lambrusco di Sorbara con quello di Reggio Emilia risulta subito evidente. Altro fattore che ci fa amare la manifestazione è la qualità dei colleghi che incontriamo; tutte persone che amano dialogare di vino con arguzia e capacità senza chiudersi in ottusità di casta ma ragionando con sensibilità sulle differenze riscontrate nei vini. Non guru ma osservatori laici ed estranei alle dispute inutili, tanto di moda. Stesso atteggiamento da parte dei produttori presenti, che non lesinano consigli indicando vini di colleghi per loro di grande interesse, senza gelosie ma animati da uno “spirito guida” verso l’interlocutore per introdurlo al territorio. L’incarnazione di questo spirito, che si respira soprattutto nel versante romagnolo , è un giovane enologo di grandissimo talento, Francesco Bordini. Quando vengo ad Enologica mi piace molto assaggiare con lui che è il primo a indicarmi vini, non delle “sue” aziende , ma quelli che lui ritiene di particolare interesse per capire il territorio, insomma scoccia dirlo ma un atteggiamento molto “francese”.
Sul fronte vini quello che si nota è una grande dinamicità del territorio che sta, pian piano e in maniera non omogenea, prendendo coscienza delle proprie caratteristiche e non si vergogna a mostrarle senza ricercare facili ammiccamenti al mercato o copiando modelli vincenti non applicabili a certi territori e vini. Questa consapevolezza permette di avere prodotti molto diversificati e interessanti, proposti a prezzi molto convenienti per il consumatore finale. Questa dinamicitàè maggiormente riscontrabile nella Romagna più che in Emilia ma penso che sia legato alla maggiore notorietà dei vitigni implicati.
Partiamo dal mio amato sangiovese. Come ebbi già modo di scrivere, il territorio romagnolo andrebbe diviso non per comune ma per fasce di altitudini e di terreni che sono decisamente più confrontabili. Le parti basse hanno una argilla profonda che sebbene dia potenza mostra spesso tannini decisamente poco addomesticabili, le parti oltre i calanchi sono molto più interessanti e dobbiamo distinguere quelle ricche in calcare da quelle più sabbiose perché danno vini profondamente diversi: più salati e concentrati i primi ed estremamente eleganti i secondi con tannini raffinatissimi e una beva molto intrigante fatta di souplesse. Tipici esempi della seconda specie sono i vini di Modigliana, che tra terreno e altezza possiamo indicare come situazione limite per la maturazione del sangiovese. Bertinoro e Predappio alto sono due chiari esempi di terreni con più calcare.
Per quanto riguarda l’Emilia il “fenomeno” Lambrusco è esploso a livello internazionale e per la prima volta siamo stati noi italiani a riscoprirlo. Ma forse è meglio notare che il pignoletto è il vitigno che sta per spiccare il volo. Coltivato su un areale piuttosto ampio nei Colli Bolognesi sta prendendo una fisionomia ben definita soprattutto nella versione ferma che ritengo molto più interessante. Le versioni spumantizzate per ora non dimostrano un grande avvenire. Le versioni ferme, grazie alle nuove tecnologie e vinificazioni moderne, hanno trovato un olfatto interessante che ben coniuga le note di erbe selvatiche come asparago, ortica, malva ad altre più floreali sia bianche che gialle. Una bella acidità di fondo dà al vino una bellissima beva. Possiamo per ora dire che la differenza dei profumi è data principalmente dall’ altezza delle vigne.
Di seguito qualche vino che mi ha decisamente impressionato.

 English
English