Il pensiero unico
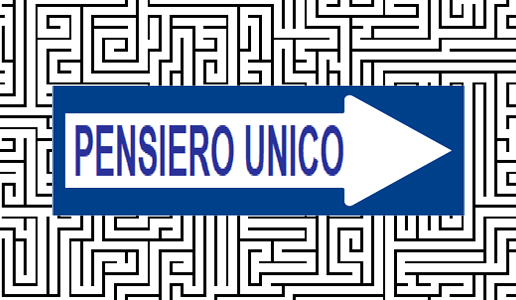
È importante evitare il rischio di un pensiero unico o prevalente, troppo spesso superficiale, modaiolo e privo di solide basi scientifiche e per questo pericoloso.
Una delle più forti convinzioni che ho nella vita sta nel fatto che ritengo pericolosa e antidemocratica ogni forma del cosiddetto pensiero unico o, più correttamente, pensiero prevalente. Che siano mode imperanti, parole d’ordine brandite come armi ideologiche, modi per distinguere in maniera inequivocabile il bene dal male, il vero dal falso, il giusto dall’errato, non fa molta differenza, secondo me. Tutto opera per evitare discussioni, ragionamenti, confronti, che rappresentano il sale della libertà e della democrazia reale.
Nel nostro mondo del vino tutto questo si concretizza in prese di posizione fiere e talvolta irrazionali, ispirate dall’emotività e da un modo ingenuo per immaginare una realtà priva di sfaccettature e di complessità, come fosse una sorta di “luogo dell’anima” nel quale rifugiarsi. Perciò i vini devono essere nell’ordine, “territoriali”, frutto di viticoltura ecosostenibile, che rinuncia a ogni forma di chimica, ottenuti con tecniche enologiche “morbide”, demonizzando solfiti, vinificazioni “in riduzione”, e uso di legni piccoli. Banditi i vitigni internazionali e auspicati vini prodotti con una sola varietà, possibilmente “autoctona” e con uso di lieviti “indigeni”. Tutto questo non può che portare, secondo alcuni, alla qualità più conclamata.
Certo, molte di queste pratiche sono auspicabili, non dico affatto di no. Ma se non si fanno distinguo, non si ragiona, non si analizzano le situazioni nel concreto, il rischio di fare delle belle teorie senza prendere atto della complessità del reale è dietro l’angolo. In buona sostanza si determinano semplificazioni confortanti ma prive di incisività e soprattutto si demonizza chi prova a ragionare su questi temi non limitandosi ad accettare pedissequamente questa sorta di politically correct e di pensiero unico.
Alcuni esempi. Va benissimo limitare l’uso di solfiti, e negli anni lo si è anche fatto, se è vero che oggi il contenuto di SO2 nella stragrande maggioranza dei vini è anche meno della metà di quanto accadeva trent’anni fa. Ma se si evita l’uso di sostanze che difendono il vino da attacchi esterni, il rischio è che si formino acetaldeide, ammine biogene, che si chiamano istamina, putrescina e cadaverina, e che sono molto più pericolose per la salute dei solfiti.
Ancora. Benissimo usare vitigni tradizionali, ma esistono zone in Italia dove la “tradizione” è rappresentata anche da merlot, e penso al Friuli e al Veneto, da chardonnay, in Trentino, da cabernet sauvignon, a Bolgheri. E poi da noi il peso di quelle varietà è minimo sul totale della produzione, e anche questo va detto.
Bene usarli come vitigni unici, a patto che questo faccia parte della tradizione nel senso più preciso del termine. Perciò utilizzare solo il sangiovese nel Chianti o a Carmignano non è un uso tradizionale, visto che quei vini da sempre sono frutto di uvaggi fra il sangiovese e piccole quantità di varietà diverse, spesso altrettanto antiche, come colorino, canaiolo, pugnitello.
Bene l’uso di tecniche viticole ecosostenibili, oggi sempre più irrinunciabili. Però anche la cisgenetica è un sistema utile per contenere in modo sensibile l’uso della chimica in vigna, e non esiste solo la biodinamica o visioni del mondo ad essa assimilabili.
Bene evitare i prodotti sistemici, a patto poi che non s’inondino i vigneti di metalli pesanti, come il rame, che per essere integrato ci mette secoli.
Provare a fare discorsi del genere, come sa chi ci legge, visto che qui sono di casa, provoca talvolta discussioni violentissime, come se chi sostiene che è necessario capire e discutere fosse un occulto supporter di chissà quali interessi di chissà quale multinazionale della chimica e non semplicemente qualcuno che vuole evitare il rischio di un “pensiero unico” troppo spesso superficiale, modaiolo e privo di solide basi scientifiche.

 English
English








